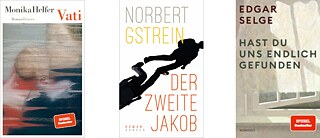Questo conflitto, tuttavia, non è stato una sorpresa: nel panorama editoriale 2021, i dibattiti e i punti di vista si sono incentrati ancora una volta su ciò che continua a essere descritto dal tormentone, tanto abusato quanto fumoso, di “politica identitaria”. Se i futuri dibattiti sulla letteratura (di lingua tedesca) sostituissero questo concetto con analisi più precise, sarebbe già un bel passo avanti. Se, in letteratura, la politica identitaria si definisce come un tentativo di rivendicare le proprie origini, la propria storia, la propria famiglia, e di indagare le strutture che le sottendono, la maggior parte dei romanzi acclamati dalla critica nel 2021 sono il risultato di considerazioni in materia di politica identitaria. La domanda che sorge anche in questo contesto è: abbiamo a che fare con un’opera esteticamente convincente?
Monika Helfer, Norbert Gstrein e Edgar Selge sono tre degli autori che nell’ultimo anno hanno pubblicato libri che, in modi completamente diversi ed eccezionali, trattano i temi delle origini e della famiglia. Dopo il grande successo di Die Bagage, con Vati l’austriaca Monika Helfer ha scritto un libro breve ma intenso in cui cerca di rintracciare il grande sconosciuto della sua vita, suo padre, che, tornato dalla Seconda guerra mondiale mutilato, dopo la morte della moglie affidò i figli ai parenti e scomparve. In Der zweite Jakob, invece, Norbert Gstrein, un austriaco residente ad Amburgo, combina con inconfondibile eleganza una sinistra serie di femminicidi con la crisi di un attore a ridosso del suo 60° compleanno, un uomo che vive nella paura di aver ereditato la psicopatologia di suo zio e che finisce per rifugiarsi nel villaggio tirolese della sua infanzia. Infine, l’attore Edgar Selge, classe 1948, è riuscito a segnare uno sbalorditivo debutto letterario con Hast du uns endlich gefunden. Qui Selge racconta dell’infanzia come figlio di un direttore di carcere, dell’atmosfera artistico-musicale che si respirava in casa sua e che tuttavia non lo ha preservato dalle percosse e dalle umiliazioni di suo padre. Un romanzo di formazione che nasce dallo spirito del miracolo economico tedesco e dai suoi anni carichi di implicazioni.
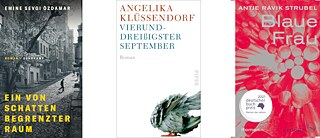
Sulla prospettiva Est-Ovest fanno luce anche due dei romanzi più acclamati dello scorso anno. In Vierunddreißigster September, Angelika Klüssendorf pone su un piano paritario i vivi e i morti di un villaggio del Brandeburgo. Da que Die Zeit scono momenti comici, ma al tempo stesso si ricorda ai lettori, quelli della Germania Ovest in particolare, che espressioni come “Est disconnesso” sono grossolane e denigratorie e non rendono neanche lontanamente giustizia alle esperienze biografiche individuali. L’ambìto Deutscher Buchpreis è stato vinto dalla scrittrice Antje Rávik Strubel con il romanzo Blaue Frau, che combina l’esperienza dello stupro con una visione più ampia del complesso rapporto tra Europa orientale e occidentale per mezzo di una narrazione magistrale e uno stile poetico. Nel suo discorso di accettazione del premio, l’autrice ha parlato di quella che definisce “la guerra che si combatte sulle etichette e sulle definizioni, cioè su chi ci è consentito essere e su chi ha voce in capitolo al riguardo”.
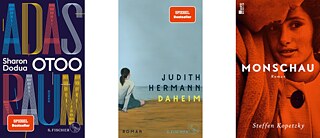
Il 2021 è stato il secondo anno di pandemia, e Steffen Kopetzky, uno degli autori più divertenti attualmente attivi in Germania, in Monschau racconta proprio lo scoppio di un’epidemia. Si tratta di quella del vaiolo, che nel 1962 dilagò nel villaggio di Monschau, nell’Eifel, a causa di un ingegnere impiegato in un’azienda produttrice di altoforni che l’aveva portata con sé dall’India. Nulla di inventato, dunque, ma il modo in cui Kopetzky costruisce una trama avvincente intorno ai fatti e allo stesso tempo mette a nudo l’impotente gestione di una malattia altamente contagiosa – funesta reminiscenza del 2020 – è un esempio di grande maestria. Anche in questo caso, dunque, negli eventi storici si riflette il presente.
Christoph Schröder, classe 1973, lavora come critico letterario freelance per Deutschlandfunk, Süddeutsche Zeitung e Die Zeit.
Libri citati:
- Sharon Dodua Otoo: Adas Raum, S. Fischer Verlag.
- Norbert Gstrein: Der zweite Jakob, Hanser Verlag.
- Monika Helfer: Vati, Hanser Verlag.
- Judith Hermann: Daheim, S. Fischer Verlag.
- Angelika Klüssendorf: Vierunddreißigster September, Piper Verlag.
- Steffen Kopetzky: Monschau, Rowohlt Berlin Verlag.
- Emine Sevgi Özdamar: Ein von Schatten begrenzter Raum, Suhrkamp Verlag.
- Antja Rávik Strubel: Blaue Frau, S. Fischer Verlag.
- Edgar Selge: Hast du uns endlich gefunden, Rowohlt Verlag.
Traduzione di Maria Carla Dallavalle
Copyright: © Litrix.de