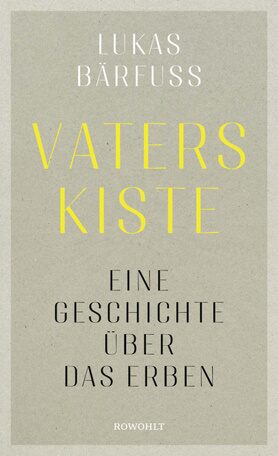Lukas Bärfuss
Vaters Kiste. Eine Geschichte über das Erben
[Lo scatolone di mio padre. Storia di un’eredità]
- Rowohlt Buchverlag
- Amburgo 2022
- ISBN 978-3-498-00341-8
- 96 pagine
- Contatto della casa editrice
Diritti già venduti
Leggi un estratto
Quel che dobbiamo ai posteri
Il saggio Vaters Kiste [Lo scatolone di mio padre] si basa sulle lezioni che Bärfuss ha tenuto all’università di Zurigo e al Teatro Nazionale tedesco di Weimar. Il sottotitolo dell’esile libretto suona: «Storia di un’eredità». Nel pensiero decisamente politico e radicalmente morale dell’autore il processo dell’eredità va ben al di là delle costellazioni private e affronta, dal punto di vista dell’umanità, «la partecipazione dei posteri di cui noi determiniamo la sorte con ciò che lasciamo loro». Con quel «noi» si intende la porzione della specie che detiene potere e ricchezza per imporre il proprio stile di vita al resto dell’umanità e definire così in che modo le generazioni future troveranno il pianeta e la civiltà.
Le sue riflessioni sui «diritti della posterità» inducono Bärfuss a un confronto con l’eredità sua propria, con le sue origini, in effetti materiale ideale per un romanzo del genere, particolarmente fiorente in Francia, della «socio autobiografia». Il suo percorso dalla povertà, dalla mancanza di istruzione e dalla condizione di senza tetto, attraverso svariati mestieri, fino alla vincita del Büchner Preis e al ruolo di professore universitario è esemplare per l’ascesa di un individuo svantaggiato che, grazie al suo sforzo intellettuale, supera la propria determinazione sociale e resta tuttavia segnato dal proprio ambiente di origine.
Tuttavia l’analisi critica della società che è insita nelle epiche biografie dei modelli francesi è proprio ciò che tiene Bärfuss separato dalla sensibilità individuale. Egli descrive il suo background familiare, la desolazione della sua giovinezza e adolescenza e la sua emancipazione avvenuta attraverso la letteratura in maniera tanto vivida quanto stringata. Semmai vuole far luce sulle cause storiche, politiche ed economiche che fanno sì che biografie come la sua restino degli sporadici casi fortunati nel contesto globale. Perché sebbene egli abbia numerose rimostranze da presentare alla sua patria svizzera, pure è ben consapevole di quale vantaggio sia stato per lui nascere in una delle nazioni economicamente più floride del mondo.
«Lo scatolone di mio padre», l’elemento scatenante di questa retrospettiva, è una scatola di cartone che viene consegnata a Bärfuss dopo che «l’uomo del quale si diceva fosse stato mio padre», la pecora nera della famiglia, era morto in solitudine su di una strada, una scatola che il figlio tenne chiusa per venticinque anni come il vaso di Pandora. Ciò che poi lo scatolone rivelò furono le testimonianze, scarne ma pregnanti, di una vita di fallimenti, attestazioni di povertà, debiti, criminalità. Tutto ciò valse a portare ancora una volta l’autore a confronto con la miseria in cui egli stesso per poco non sarebbe sprofondato. E diede il via a una catena di pensieri in cui Bärfuss mette in relazione le condizioni attuali della sua, della nostra società con il passato e con il futuro. Questo accade in maniera discontinua, per associazioni di idee, con audacia assertiva e distinzioni nette, per bordate e considerazioni dettagliate, ma sempre sulla base, in egual misura, di letture e di impressioni dirette.
In tutto questo si tratta di diritto ereditario e di proprietà privata, dell’Origine delle specie di Darwin e dell’invenzione dello Stato nazionale, di antropologia sociale e di metafisica, di linguaggio e democrazia, di tecnologia e disuguaglianza. Si tratta di eredità spirituale e di spazzatura profana, di guerra, delle scie di condensazione nel cielo e della Tomba dei patriarchi a Hebron, di inganni e bugie, e della questione: «che cosa intendiamo passare sotto silenzio e quando?». E intanto si tratta sempre di nuovo del padre che, nonostante i presupposti più favorevoli, a differenza del figlio non riuscì ad accedere a una vita borghese.
Attraverso tali contraddizioni, Bärfuss traccia un arco dalla genesi al presente per trarre dai suoi ritrovamenti concrete proposte di azione che tengano conto della responsabilità verso l’eredità delle generazioni future. Può sembrare avventuroso, e in effetti lo è. Alla fine si riconosce che Lukas Bärfuss traccia una drammatica linea guida per pensare la nostra situazione. E non c’è quasi nulla di più urgentemente necessario in questi tempi disorientati ed esistenzialmente minacciosi.
Tradotto da: Alessandra Iadicicco

di Kristina Maidt-Zinke
Kristina Maidt-Zinke, critica letteraria e musicale, scrive per la Sueddeutsche Zeitung e collabora alla pagina dei libri della Zeit.
Scheda della casa editrice
Lukas Bärfuss ha rifiutato l’eredità di suo padre, fatta perlopiù di debiti. È rimasta soltanto una scatola che Lukas esamina attentamente per la prima volta dopo venticinque anni e che lo riporta alla sua infanzia difficile, a una gioventù sulla strada. Le domande si fanno pressanti: che cosa ha ereditato lui da un padre assente e criminale? Che ne è di un diritto di successione finalizzato al possesso personale che, pur avendo appena cent’anni, ci appare come una legge di natura? Che ne è della responsabilità al di là del legame familiare, della partecipazione dei nostri discendenti, di cui determiniamo il destino con ciò che lasciamo, con la nostra eredità, con i nostri rifiuti? Non sarà possibile trovare risposte finché il pensiero pianificatore chiuderà gli occhi di fronte alla scomparsa di tutte le evidenze, finché rifiuterà una disillusione che ci permetterebbe di rispondere alle domande importanti: vogliamo continuare a vivere come abbiamo fatto finora?
E se no, come fare?
(Testo: Rowohlt Buchverlag)