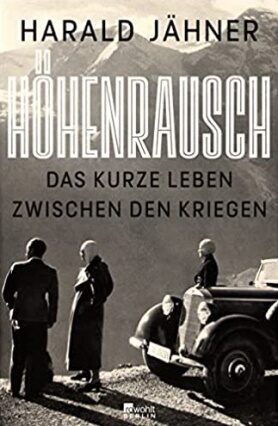Harald Jähner
Höhenrausch. Das kurze Leben zwischen den Kriegen
[Vertigine. La breve vita tra le due guerre]
- Rowohlt Buchverlag
- 2022
- ISBN 978-3-7371-0081-6
- 560 pagine
- Contatto della casa editrice
Leggi un estratto
Vertigine e caduta a Berlino tra le due guerre
Harald Jähner, già responsabile della pagina culturale della «Berliner Zeitung» e autore pluripremiato di narrativa storica, in Höhenrausch. Das kurze Leben zwischen den Kriegen si è dedicato a quel complesso di fenomeni che in Germania tra le due guerre mondiali hanno reso possibile un sentimento di svolta epocale tanto inebriante quanto spaventoso. Il risultato è una fenomenologia virtuosa, strutturata per temi, presentata in modo narrativo, puntuale e, non da ultimo, avvincente, come un romanzo sociale in cui i motivi morali, tecnici, politici ed erotici si fondono l’uno nell’altro e si trasformano a loro volta in fenomeni nuovi.
Nella nuova epoca, tutto era – appunto – nuovo. E il nuovo era per lo più veloce – più veloce di prima, quantomeno: il traffico, le telecomunicazioni, la stampa, il ballo, che con lo shimmy di ultimo grido improvvisamente non era più ballo da sala, bensì da soli, per individualisti – e soprattutto individualiste – amanti del divertimento.
Tutto ciò che riguardava la nuova epoca si presentava con fulmineità. Questo vale anche per i processi di emancipazione, che, a dire il vero, rimasero più che altro un fenomeno delle grandi città. Mai la mobilità sociale tedesca fu maggiore che negli anni Venti a Berlino, dove improvvisamente emersero nuove prospettive di vita anche per le ragazze di estrazione operaia, in particolare impiegate come centraliniste e segretarie. Così, secondo Jähner, le donne della classe lavoratrice entrarono in contatto con le maniere dei colti: «Non mangiavano la zuppa nella gavetta come i loro fratelli proletari, ma pranzavano con le colleghe in mensa o addirittura nelle trattorie a sottoscrizione. […] A casa», continua Jähner, «erano loro a leggere e spiegare ai genitori le lettere delle autorità».
Ma l’autore conosce l’ambivalenza del fenomeno. Le ragazze di città emancipate in ufficio sono una faccia della medaglia. Le prime fasi del sessismo istituzionalizzato sono l’altra. «La vita d’ufficio era animata da forze di attrazione e sogni di carriera, ma anche avvelenata da cinico sfruttamento, calcolo e tragedie d’amore». Mentre la «donna nuova», in quanto fenomeno teorico e di costume, faceva più impressione sulla borghesia colta (come nel caso di Erika Mann, Clärenore Stinnes e Maria Therese Hammerstein, nelle loro macchine sportive), l’emancipazione della piccola impiegata prendeva avvio negli innumerevoli locali da ballo della città. Qui si portavano suole chic e un pratico caschetto, quando non addirittura i capelli corti. Naturalmente, il ritmo del ballo era il doppio rispetto ai tempi passati. Taluni considerarono questo fenomeno il tramonto della cultura borghese.
Quello di Jähner è il panorama di un’epoca, ed è sempre emozionante anche quando sembra calzare a pennello con il nostro presente. Nel continuo andirivieni tra militarismo, rivoluzione e revanscismo, e nel difficile percorso di riconciliazione sotto la guida di Ebert, un presidente drammaticamente poco carismatico, i paralleli con l’oggi diventano evidenti. «‘Non avere un proprio posto’, ‘vivere e basta’ divenne un peso rispetto ai molti che si lasciavano infiammare da dilaganti visioni di liberazione», scrive Jähner, citando Georg, l’esitante eroe di Siegfried Kracauer nell’omonimo romanzo del momento.
Jähner, poi, raccorda sapientemente le preoccupazioni degli intellettuali malinconici con la filosofia sociale di un certo Helmuth Plessner, che nel suo Grenzen der Gemeinschaft, del 1924 [I limiti della comunità, trad. Bruno Accarino, Roma-Bari, Laterza 2001], elaborò una teoria comportamentale sulla civiltà urbana anonima che tuttora affascina. Si tratta della giusta distanza tra individui, che devono muoversi nel trambusto della metropoli, né troppo vicini, né troppo lontani. Con «tatto», Plessner vide la società atomizzata – che, nella collera delle destre, non era più una comunità – crescere fino a diventare una bella pluralità. Ecco perché il concetto liberale di società, nella costruzione teorica delle destre, divenne un nuovo concetto polemico. «Nella comunità, la coesione è definita in base alla discendenza e ai valori comuni della tradizione; nella società, tramite le regole date dalla coesistenza di persone potenzialmente estranee l’una all’altra». Harald Jähner cita Helmut Lethen, studioso di scienze della cultura, con una frase quasi aforistica: «Quando il traffico diventa il topos principale, le creature che vogliono mettere radici non se la passano tanto bene».
Senz’altro, anche questa diagnosi potrebbe essere applicata all’inquieto Zeitgeist di oggi. L’euforia e la distopia tecnologica, la mobilità sociale verso l’alto e i drammi dell’arretramento degli emarginati, i momenti felici della ragione e i vaneggiamenti dei confusionari andavano di pari passo anche nella Repubblica di Weimar. Sappiamo come sono andate le cose, ma Harald Jähner lo ripete e lo racconta per chi vorrebbe rimettere lo spirito del liberalismo nel vuoto a perdere da cui non è mai uscito: il liberalismo, come dimostra questo libro, è il prodotto di una società metropolitana in fermento e in attività tra le due guerre.
Tradotto da: Lia Bruna

di Katharina Teutsch
Katharina Teutsch è giornalista e critico culturale. Scrive, tra gli altri, per Frankfurter Allgemeine Zeitung, die Zeit, das Philosophie Magazin e Deutschlandradio Kultur. È membro della giuria del Leipziger Buchpreis.
Scheda della casa editrice
Germania, 1918. Fine della Prima guerra mondiale, rivoluzione, vittoria della democrazia. Nello stesso periodo inizia la marcia trionfale di una vita che ha ritrovato la sua libertà. L’inflazione fa vacillare i valori tradizionali. Tutto deve essere totalmente rivoluzionato: si parla di “donna nuova”, “uomo nuovo”, “vivere nuovo”, “pensiero nuovo”. Quando, a metà degli anni ’20, anche l’economia riprende quota, la Germania diventa un Paese diverso. Le donne conquistano i circuiti automobilistici e i campi da tennis, escono da sole la sera, sfoggiano tagli di capelli corti e non pensano al matrimonio. La moda è improntata all’unisex, all’androgino e alla sperimentazione. Harald Jähner racconta dell’invenzione del tempo libero, delle palestre di boxe e delle sale da ballo, e degli hotspot della nuova epoca, degli uffici e del traffico urbano, dei grandi magazzini come promessa di felicità o della strada come luogo di feroci battaglie. Tutte cose che oggi appaiono incredibilmente moderne. La predilezione per l’ironia, la schiettezza e la franchezza. Ma anche la paura della “svalutazione di tutti i valori”, il dominio del basso costo. La maggior parte dei tedeschi non si ritrovava in questa epoca di grandi cambiamenti. Via via che il denaro diventava più scarso e il futuro più cupo, la profonda spaccatura della società e l’incapacità di sopportarla si facevano sempre più evidenti.
Harald Jähner offre una panoramica di questo periodo così ricco e vibrante e dipinge il ritratto di un Paese lacerato e pieno di energie tanto potenti quanto terribili. Una situazione spaventosamente simile alla nostra, eppure – si spera – molto diversa.
(Testo: Rowohlt Buchverlag)